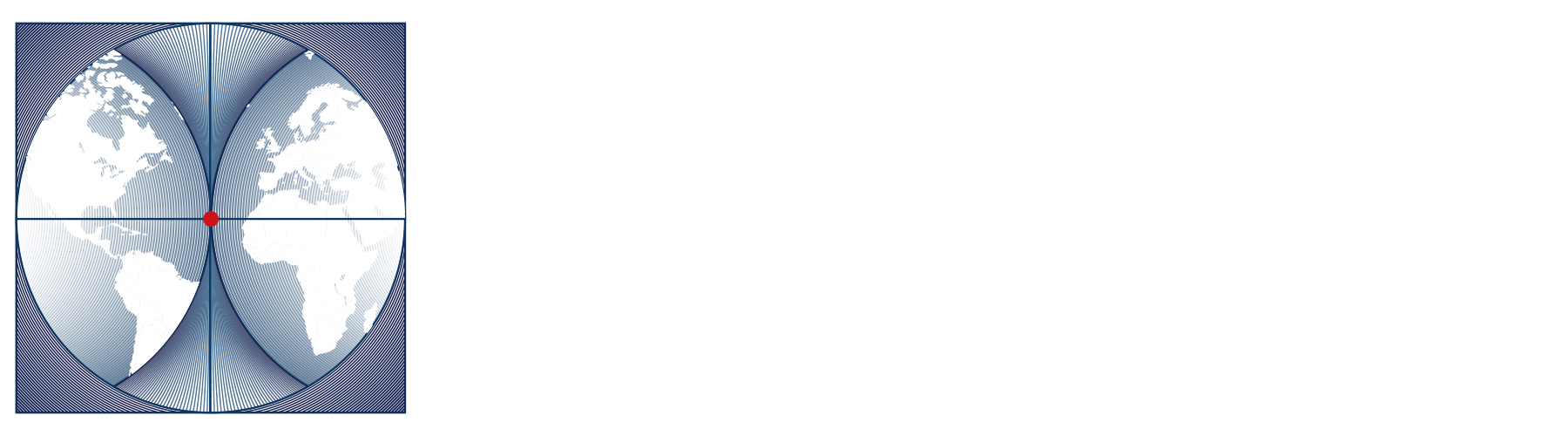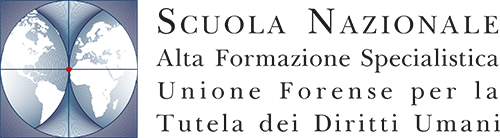di Sara Tosi
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 96 del 9 giugno 2025, è tornata ad interrogarsi sui limiti costituzionali attinenti alla restrizione della libertà personale, affrontando, questa volta, il tema dei trattenimenti nei centri di permanenza per i rimpatri ex art. 14 del Testo unico sull’immigrazione.
L’impulso deriva dal Giudice di pace di Roma, il quale solleva due distinte questioni di legittimità costituzionale.
Dapprima, lamenta la mancanza di una disciplina puntuale dei modi mediante i quali viene effettuato il trattenimento, specie alla luce del pressoché integrale rinvio in tal senso a fonti subordinate (nello specifico, al d.p.r. n. 394 del 31 agosto 1999), il che non tiene conto della riserva assoluta di legge prevista dalla nostra Costituzione per le ipotesi di restrizione della libertà personale. Tale vuoto di tutela comporterebbe, dunque, la violazione degli artt. 13 e 117 Cost., oltre che dell’art.5 Cedu.
D’altro canto, ravvisa un’inesistenza di tutele giurisdizionali, in quanto non sia nemmeno presente l’indicazione dell’autorità competente a controllare la legalità di simili restrizioni. Difatti, la situazione di coloro che si ritrovano trattenuti in tali centri è ancor più sprovvista di garanzie rispetto a quella dei detenuti nelle case circondariali, per i quali è quantomeno previsto il rimedio dell’art. 35 bis ord. pen. Questo, porta il rimettente a sostenere un contrasto con gli artt.2, 3, 10, 24, 25, 31, 111 Cost.
Orbene, la Corte costituzionale ha ritenuto effettivamente esistente un vulnus di tutela.
Il riferimento è alla riserva assoluta di legge, poiché la disposizione censurata reca una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i «modi» della restrizione, così come i diritti delle persone trattenute. In tal senso, essa rammenta come, alla luce dell’art. 13 co. 2 Cost., la fonte primaria debba prevedere non soltanto i «casi» di restrizione della libertà personale, ma altresì i «modi» mediante i quali questa possa avvenire (così la Corte richiama una serie di precedenti sentenze, tra cui la n. 25 del 2023 e la n.22 del 2022).
Essendo dunque la disciplina essenzialmente rimessa, come lamentato dal rimettente, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali, la Corte sostiene che il legislatore sia venuto meno all’obbligo positivo imposto dall’art.13 Cost., tentando di eludere la riserva assoluta di legge in esso prevista.
Ciononostante, le questioni sollevate vengono dichiarate inammissibili, rammentando che non rientri tra i compiti della Consulta quello di porre rimedio alla mancanza di una normativa compiuta che assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone trattenute. Tale dovere ricade inevitabilmente in capo al legislatore, al quale spetterà attivarsi al fine di far cessare la situazione oggi presente nei luoghi di cui si discute. D’altra parte, sul piano dei rimedi processuali, la Corte ravvisa la possibilità di avvalersi dell’art. 700 c.p.c., sottolineando, tuttavia, che ciò non faccia venir meno il vuoto di tutela e, nemmeno, la conseguente necessità d’intervento.