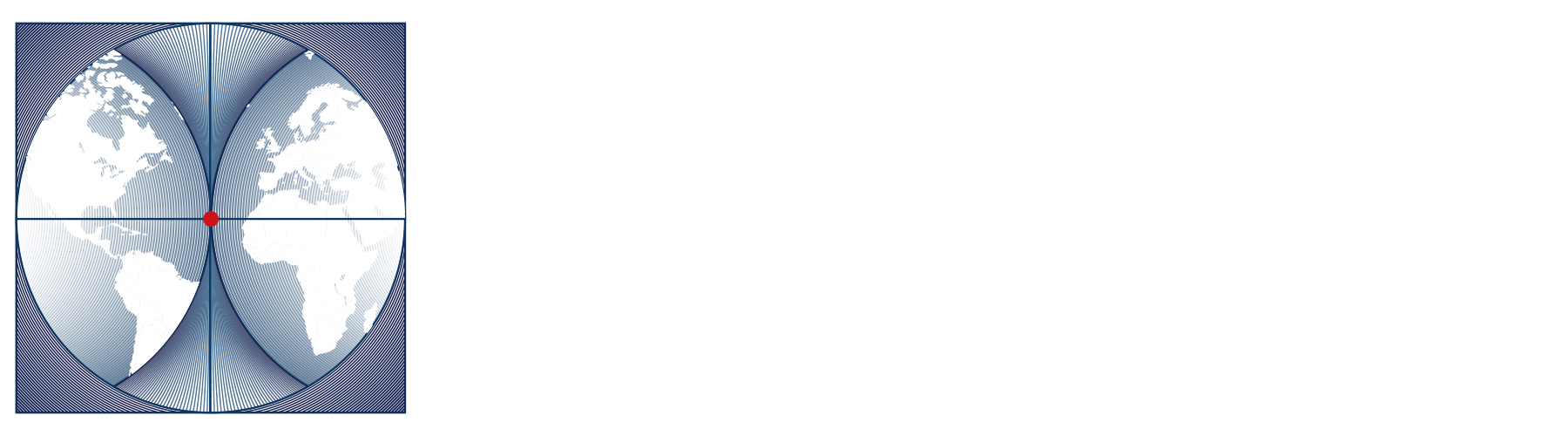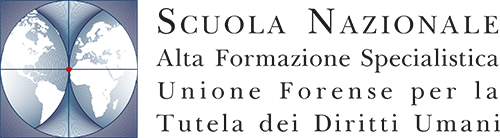di Mariateresa Veltri
Con due recenti provvedimenti cautelari, del 6 agosto 2025 e del 9 agosto 2025, il Tribunale ordinario di Roma – Sezione diritti della persona e immigrazione ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e alla Rappresentanza consolare italiana in Israele di rilasciare visti di ingresso con validità territoriale limitata per motivi umanitari, ai sensi dell’art. 25, par. 1, lett. a), Reg. (CE) n. 810/2009 (“Codice Visti”) e dell’art. 6, par. 5, lett. c), Reg. (UE) n. 2016/399 (“Codice Frontiere Schengen”), a favore di nuclei familiari palestinesi rifugiati UNRWA e tuttora intrappolati nella Striscia di Gaza.
I decreti, adottati inaudita altera parte, si fondano su una ricostruzione dettagliata della catastrofe umanitaria in atto, documentata da fonti ONU (UNRWA, OCHA, OMS), che espone i ricorrenti a grave, attuale e irreparabile pericolo per la vita e l’incolumità fisica.
Il Tribunale ha ritenuto che sussistesse il fumus boni iuris sulla base di diversi obblighi giuridici:
- costituzionali: art. 10, co. 3, Cost.;
- convenzionali: artt. 2 e 3 CEDU;
- internazionali: in particolare la Convenzione ONU sul genocidio del 1948 e l’ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 24 gennaio 2025 (South Africa v. Israel).
Quest’ultima ha considerato plausibile la perpetrazione di un crimine di genocidio nei confronti della popolazione palestinese di Gaza, con conseguente obbligo per gli Stati terzi di intervenire per prevenirne o limitarne gli effetti, richiamando diversi rapporti internazionali. Tra questi, in relazione alle responsabilità italiane per la fornitura di armi a Israele, viene citato da ultimo il Rapporto della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati.
Il periculum in mora, strettamente connesso alla situazione di fatto, è stato ritenuto integrato dal rischio concreto e attuale di lesioni irreversibili ai diritti fondamentali dei ricorrenti e dei loro figli minori. Particolarmente rilevante è l’ordinanza del 9 agosto 2025, che ha chiarito come l’obbligazione statale non si esaurisca nel mero rilascio formale del titolo di ingresso, ma si configuri quale “obbligazione di mezzi rafforzata”, imponendo all’Amministrazione di farsi parte attiva nel porre in essere ogni iniziativa diplomatica, consolare e operativa idonea a rendere effettivo l’ingresso dei beneficiari, abbandonando una posizione di passiva attesa.
In questa prospettiva, il rilascio del visto umanitario non è considerato una mera facoltà discrezionale, bensì uno strumento giuridico necessario per evitare la violazione irreversibile di diritti inviolabili, in linea con l’interpretazione già offerta dalla giurisprudenza nazionale (Cass. SS.UU. n. 29460/2019; Corte d’Appello di Roma, 11 gennaio 2021) e sovranazionale (CEDU, Al-Skeini; Bankovic), che, con le parole del Giudice, “impongono un dovere di protezione attiva verso una popolazione a rischio”. Dunque, sebbene l’Ambasciata sia dotata di potere discrezionale, tale discrezionalità incontra i limiti del rispetto degli obblighi nazionali e internazionali (nei provvedimenti vengono richiamati l’art. 10 co. 3 Cost. e l’art 8 CEDU).
I giudici ribadiscono che la normativa europea in materia di visti è direttamente applicabile e deve essere letta in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale sancisce il diritto d’asilo (art. 18) e il principio di non-refoulement (art. 19, par. 2). Sebbene la CGUE, nel caso X e X c. Belgio (C-638/16 PPU), abbia chiarito che gli Stati membri non sono obbligati a rilasciare visti umanitari sulla base del Codice Visti al di fuori del territorio dell’Unione, il Tribunale di Roma valorizza un diverso profilo, vale a dire la combinazione tra discrezionalità consolare e obblighi inderogabili derivanti da fonti costituzionali e internazionali.
In questo senso, tali decisioni evidenziano come la discrezionalità statale, pur riconosciuta dalla normativa UE, debba essere esercitata nei limiti posti dal diritto internazionale cogente e dai diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento unionale, così da evitare che la mancanza di accesso materiale ai servizi consolari renda illusorio il diritto di chiedere protezione internazionale.
Tuttavia, come denunciato dall’ASGI nel comunicato del 23 agosto 2025¹, esse rischiano di rimanere inattuate a causa della persistente inerzia del governo italiano, che non ha ancora attivato i necessari canali diplomatici e operativi. L’associazione, che segnala anche ulteriori decisioni cautelari in linea con questo orientamento, ha sottolineato come l’inerzia ministeriale, in presenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi, possa configurare non solo una violazione grave dello Stato di diritto, ma anche una responsabilità internazionale per inosservanza della Convenzione sul genocidio e del principio di non-refoulement.
In conclusione, i decreti del Tribunale di Roma rappresentano un passo decisamente significativo nella giurisprudenza italiana in materia di protezione internazionale, in quanto valorizzano il visto umanitario ex art. 25 del Codice Visti non come mero atto discrezionale, ma come strumento vincolato volto a garantire diritti fondamentali. Esse chiariscono in modo netto che lo Stato ha obblighi positivi di protezione e di attivazione, anche sul piano diplomatico, per rendere effettivo l’ingresso dei beneficiari. Tuttavia, la reale efficacia di tali decisioni dipenderà dalla loro concreta attuazione: senza un immediato impegno operativo da parte delle autorità competenti, il rischio è che la tutela giurisdizionale rimanga formale, compromettendo l’effettività dei diritti tutelati dal diritto nazionale, europeo e internazionale.