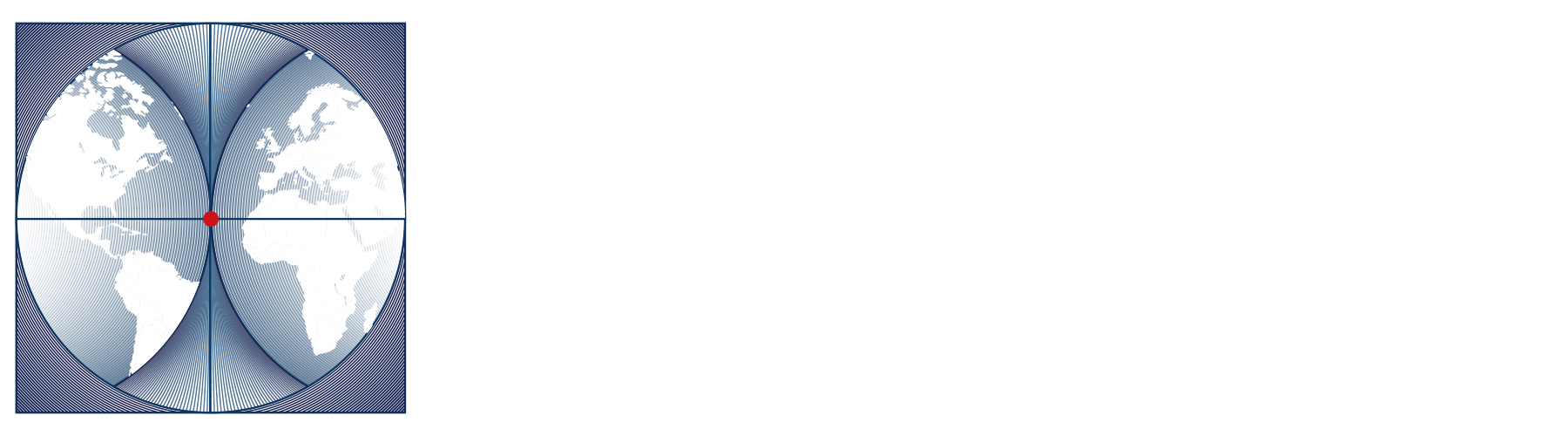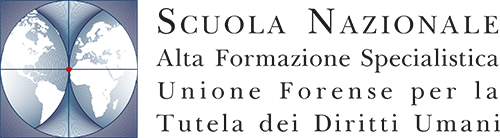di Maria Giusy Schiavone
Con una sentenza del 1° agosto 2025 (cause riunite C-758/24 e C-759/24), la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su questioni di grande rilievo sollevate, in via incidentale, dal Tribunale ordinario di Roma in materia di diritto d’asilo e, in particolare, sulla nozione di “paese di origine sicuro”.
Il caso ha origine dalla domanda di protezione internazionale presentata da due cittadini del Bangladesh, dopo essere stati soccorsi in mare e trattenuti in un centro di permanenza gestito dall’Italia in Albania. Le loro istanze sono state respinte in esito ad una procedura accelerata di frontiera perché i due istanti erano considerati provenienti da un “paese di origine sicuro”, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 158/2024, che ha inserito direttamente in un atto legislativo l’elenco degli Stati considerati sicuri.
I due cittadini del Bangladesh hanno presentato ricorso al Tribunale ordinario di Roma avverso le decisioni di rigetto delle loro domande di protezione internazionale e, nell’ambito di tale procedimento, il giudice italiano ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali riguardanti:
- la legittimità della designazione di uno Stato terzo come Paese di origine sicuro tramite legge;
- la mancanza di accessibilità delle fonti adoperate per giustificare tale designazione;
- la possibilità per i giudici di utilizzare informazioni indipendenti per verificare la fondatezza della scelta statale;
- la compatibilità con il diritto dell’Unione della possibilità di designare un Paese come “di origine sicuro”, nonostante vi siano, in tale Paese, categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni sostanziali di siffatta designazione.
La Corte di Lussemburgo nella sua decisione, pur riconoscendo che gli Stati membri sono liberi di utilizzare strumenti legislativi primari per designare i paesi di origine sicuri, ha chiarito che tale scelta deve comunque garantire il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. I giudici europei infatti hanno affermato che, sebbene gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, non ostino a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, ciò non deve pregiudicare la possibilità per i giudici di effettuare un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate nell’allegato I a detta direttiva.
Un altro punto centrale riguarda la trasparenza: gli Stati devono rendere accessibili le fonti informative sulle quali si basano per dichiarare sicuro un paese terzo, affinché i richiedenti asilo possano contestarle e i giudici possano valutarne attendibilità, pertinenza e aggiornamento. In assenza di questa pubblicità, sarebbe compromesso il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Non solo: i giudici possono e devono avvalersi di tutte le informazioni pertinenti disponibili, siano esse informazioni pubbliche, incluse quelle fornite da UNHCR, EUAA e organizzazioni internazionali, oppure documenti di cui il giudice ha chiesto la produzione alle parti della controversia.
Infine, la Corte ha escluso la possibilità di qualificare come sicuro un paese che non lo sia per alcune categorie della sua popolazione. Sul punto, i giudici hanno affermato chiaramente che “gli Stati membri possono designare paesi di origine sicuri, conformemente all’allegato I a detta direttiva. […] I criteri enunciati in tale allegato non forniscono alcuna indicazione secondo cui gli Stati membri avrebbero la possibilità di designare un paese terzo come paese di origine sicuro pur quando, per talune categorie di persone all’interno della popolazione di tale paese, i criteri sostanziali previsti da tale allegato I non siano soddisfatti. […] Essi esprimono quindi la scelta del legislatore dell’Unione di subordinare la designazione di un paese di origine sicuro alla condizione che il paese terzo sia, generalmente, sicuro per tutta la sua popolazione e non solo per una parte di essa”.
Questa decisione assume un’importanza cruciale per la tutela dei diritti fondamentali. Da un lato, riafferma la centralità del controllo giurisdizionale e l’impossibilità di trasformare una valutazione politica in un automatismo sottratto a verifica; dall’altro, ribadisce che il diritto d’asilo resta una garanzia individuale e che ogni domanda deve essere valutata con attenzione sulla base delle condizioni personali del richiedente.