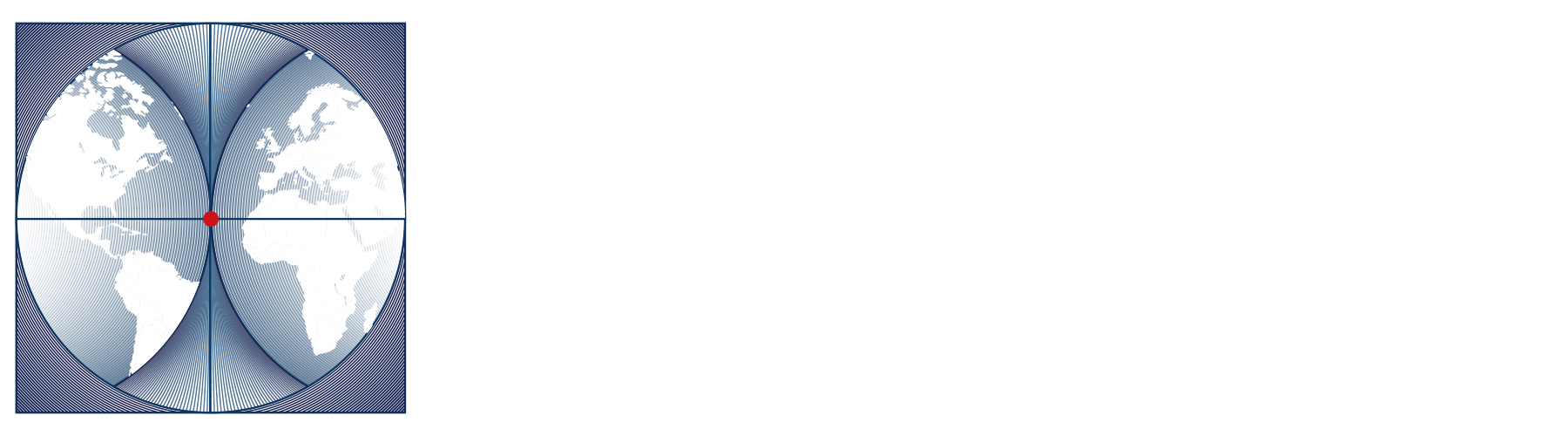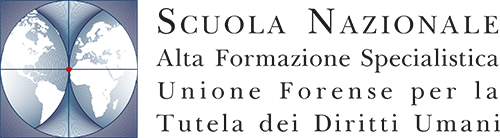di Marialessia Tritta
Con la sentenza n.101/2025, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge n.130/2020, come modificato dal d.l. n.1/2023, che prevede sanzioni pecuniarie e il fermo amministrativo delle navi il cui comandante non fornisca le informazioni richieste o non si uniformi alle indicazioni delle autorità competenti per la ricerca e il soccorso in mare, comprese quelle operanti in aree SAR estere.
Nel giudizio in via incidentale del Tribunale di Brindisi, è emersa la questione della compatibilità della disposizione con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani. In particolare, veniva denunciato il rischio che l’esecuzione automatica degli ordini provenienti dalla Guardia costiera libica – spesso non formalizzati e provenienti da un contesto istituzionale segnato da gravi violazioni – potesse condurre a operazioni di respingimento verso porti non sicuri, in violazione del principio di non-refoulement, sancito dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, nonché degli articoli 3 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vietano la tortura e i trattamenti inumani e impongono un ricorso effettivo contro tali violazioni.
La Corte ha ritenuto infondate le censure, ma non senza precisazioni rilevanti. In primo luogo, ha riconosciuto la natura punitivo-afflittiva del fermo amministrativo, con ciò estendendo alla sanzione le garanzie costituzionali tipiche della materia penale, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU. Sotto questo profilo, ha ribadito che qualsiasi misura limitativa deve essere conforme al principio di legalità e proporzionalità.
La Corte ha escluso che la norma impugnata configuri un generico rinvio agli ordini delle autorità straniere. Al contrario, ha chiarito che le indicazioni da parte di un’autorità SAR (nazionale o estera) sono vincolanti solo se legalmente impartite e conformi alle disposizioni della Convenzione SAR del 1979 e del diritto internazionale vigente.
L’inosservanza, dunque, è sanzionabile solo se l’ordine si presenta come legittimo sia sul piano formale sia sostanziale. Di conseguenza, non può essere punito il comandante che disattenda indicazioni contrarie ai diritti fondamentali delle persone soccorse, come nel caso di un ordine che imponga lo sbarco in un porto non sicuro.
Questo passaggio è cruciale, perché riporta l’intero impianto sanzionatorio entro i limiti imposti dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio, con particolare riguardo al divieto assoluto di tortura e trattamenti degradanti e al dovere di garantire uno sbarco in un luogo sicuro. La Corte ha richiamato l’obbligo degli Stati di cooperare nelle attività di soccorso in mare senza che ciò comporti compressione dei diritti delle persone migranti, riaffermando il primato della protezione umanitaria.
La decisione della Corte rappresenta un significativo richiamo ai principi del diritto del mare e ai doveri derivanti dal rispetto dei diritti umani, imponendo agli organi amministrativi e ai giudici ordinari una lettura della norma conforme agli standard internazionali. Resta aperta una questione cruciale: in che misura, nella prassi, le autorità amministrative e giudiziarie italiane garantiranno una valutazione effettiva della legittimità degli ordini impartiti da autorità estere, e in particolare di quelli provenienti dalla Guardia costiera libica, le cui condotte – come denunciato da numerosi organismi delle Nazioni Unite – si pongono spesso in contrasto con i principi fondamentali di legalità, trasparenza e tutela della dignità umana. In definitiva, la sentenza n.101/2025 riafferma un principio essenziale: la legalità formale non può mai prescindere dal rispetto sostanziale dei diritti umani. E in mare, più che altrove, il diritto internazionale non può essere invocato solo per disciplinare i limiti della navigazione: deve essere il primo fondamento della tutela della vita e della dignità di ogni persona soccorsa.