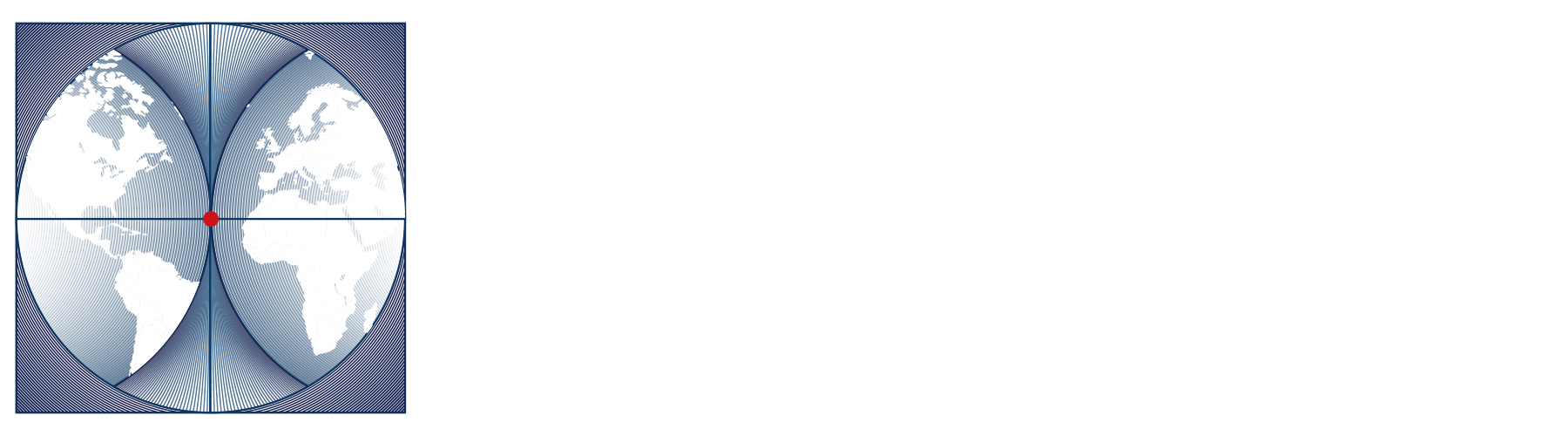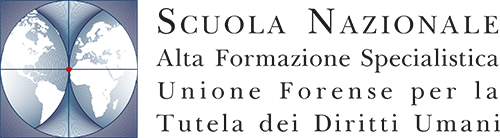Di Daniela Mainenti*
Il recente insediamento del governo afgano a guida Talebana comporta una più avvertita attenzione al tema della segregazione di genere al quale non può essere estraneo il mondo occidentale.
In tutti i conflitti della storia, la sottrazione dei diritti è stata l’espressione più visibile del predominio di una parte sull’altra. Il tema da porsi, pertanto, è la risposta alla domanda se tale forma di “apartheid di genere” possa essere considerata una questione solo territoriale afgana o, viceversa, se non debba essere valutata come un crimine contro l’umanità di genere come quella razziale. L’Economist di recente ha pubblicato uno studio congiunto di Valerie Hudson della Texas A&M University e Donna Lee Bowen e Perpetua Lynne Nielsen della Brigham Young University che ha dimostrato quanto la discriminazione delle donne renda gli Stati più fragili. Le autrici hanno valutato 176 Paesi su una scala da o a 16 per quella che chiamano la «sindrome patrilineare/fraterna» (l’idea che cioè il potere si trasmetta in linea maschile e sia in mano a una fratellanza di uomini) dimostrando come il risultato, sorprendentemente, sia il miglior predittore dell’instabilità violenta di quanto lo siano il reddito, l’urbanizzazione o dell’indice del buon governo della Banca Mondiale. Se trasponiamo questo dato in termini culturali nel nostro Paese e lo caliamo sui due dati impressionanti del 2021: ossia 47, mentre scriviamo, vittime per femminicidio e ben 60 mila soggetti schedati dentro la banca dati applicativo interforze, “ Scudo” ci rendiamo conto quanto la traslazione estrema del modello culturale talebano, inteso come visione maschile della realtà, alle nostre latitudini produca, in un modo non poi così tanto remoto, 60 mila schedati che sono un esercito di soggetti pericolosi liberamente circolanti. Sarebbe auspicabile cominciare a strutturare la segregazione di genere, attraverso una serie di divieti/limiti, come quello allo studio, all’iniziativa economica, allo sport, alla musica, alle arti e molti altri come un crimine ai diritti umani osservando specialmente, con preoccupata attenzione, le scelte politiche di paesi come la Turchia e, in itinere, Ungheria e Polonia, che stanno recedendo dalla Convenzione di Istanbul.
* Professore straordinario in diritto processuale penale comparato dei paesi Euro-Med presso la facoltà di economia e governo d’impresa della Università UniNettuno