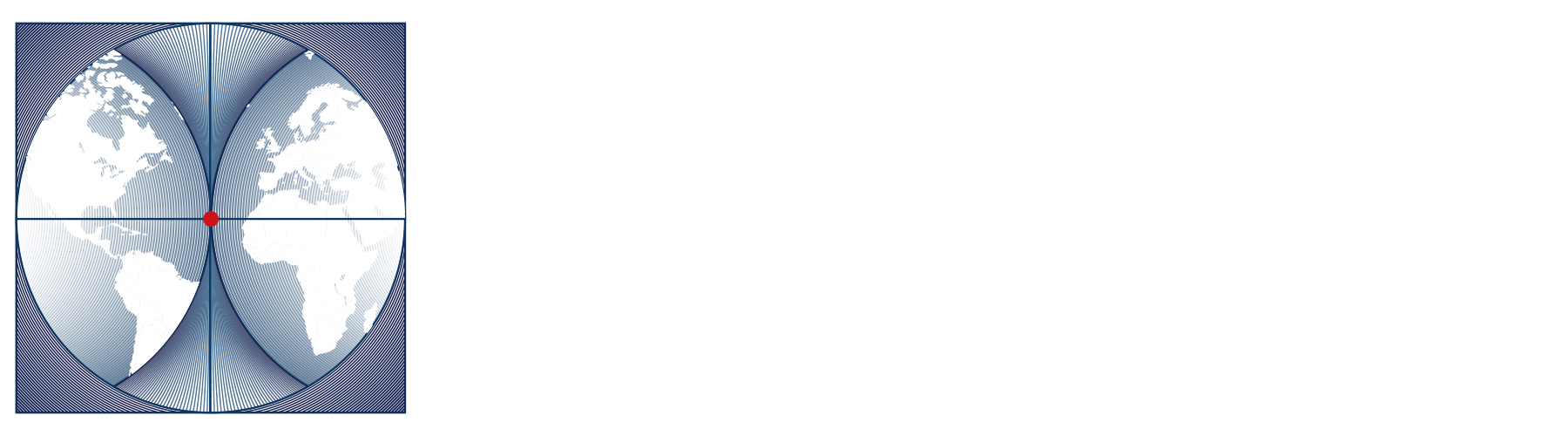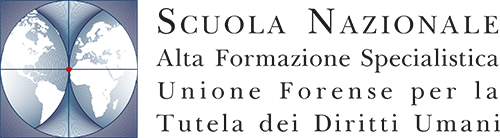di Sara Tosi
Il 20 maggio 2025, la Corte di Strasburgo si è pronunciata relativamente all’ammissibilità di un caso riguardante la tutela dei diritti fondamentali dei migranti.
I diciassette ricorrenti, di nazionalità nigeriana e ghanese, fanno parte di un gruppo di circa centocinquanta persone che, nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2017, hanno lasciato la Libia a bordo di un gommone con l’obiettivo di raggiungere le coste europee. Il 6 novembre 2017, il «MRCC» (Maritime Rescue Coordination Centre), a fronte di una richiesta di soccorso dall’imbarcazione, che si trovava a 33 miglia marine a nord di Tripoli, si attiva per garantire un pronto intervento. Nonostante l’offerta di intervenire della nave olandese Sea Watch, ad arrivare per prima è la Ras Jadir, in qualità di «nave responsabile del salvataggio in loco». Questo accade poiché, secondo il governo, il luogo dell’intervento si trovava all’interno della zona marittima di ricerca e soccorso (la «zona SAR») di competenza della Libia. Per tale ragione, il MCRR aveva chiesto anche al Centro di coordinamento aeromarittimo (Joint Rescue Coordination Center – il «JRCC») di Tripoli di assumere il coordinamento delle operazioni di soccorso. È così dunque che si attiva la Ras Jadir. Tuttavia, tale soccorso non ha avuto un esito particolarmente fausto. Infatti, le manovre effettuate dalla nave libica hanno provocato un movimento dell’acqua che ha causato la morte di diverse persone a bordo del gommone, le quali sono state bruscamente proiettate in acqua. Inoltre, l’equipaggio della Ras Jadir non ha fornito giubbotti di salvataggio ai naufraghi e ha colpito con delle corde le persone che si trovavano in mare, minacciandole con delle armi. Da quel momento, alcuni ricorrenti sono fuggiti per raggiungere la SW3 che li ha poi portati in Italia, mentre altri sono rimasti sulla Ras Jadir, dove sono stati picchiati, minacciati e condotti in un campo di detenzione a Tajura, in Libia, dove hanno subito maltrattamenti e violenze, per poi essere rimpatriati in Nigeria.
A fronte di ciò viene dunque presentato ricorso alla Corte EDU, la quale lo ha dichiarato irricevibile, sulla base del fatto che, pur riconoscendo la gravità delle circostanze e la problematicità del sistema di collaborazione tra Italia e Libia nella gestione dei flussi migratori, non si possa parlare di giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 1 della Convenzione. Infatti, l’evento si era svolto in acque internazionali, in una zona non ricompresa nella regione SAR italiana, e nessuna delle imbarcazioni coinvolte era sotto comando o controllo, de jure o de facto, italiano. In sostanza, né il solo coordinamento iniziale del MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), né il supporto tecnico e finanziario fornito alla Libia sono stati ritenuti sufficienti a fondare una responsabilità internazionale dell’Italia.
Inoltre, la Corte ha chiarito che, sebbene il diritto del mare e altri obblighi internazionali impongano agli Stati oneri di soccorso e protezione, essa è competente soltanto a giudicare in base alla CEDU e non anche relativamente ad altri obblighi internazionali. Dunque, in mancanza di un “controllo effettivo” sui ricorrenti da parte dell’Italia, non è configurabile una giurisdizione ai sensi dell’art. 1 CEDU, condizione necessaria per valutare le eventuali violazioni dei diritti convenzionali.
La decisione, presa all’unanimità, rappresenta un passaggio rilevante nel dibattito sul principio di non-refoulement e sulla responsabilità degli Stati europei nelle operazioni di esternalizzazione del controllo migratorio. Tuttavia, essa si basa su un’impostazione restrittiva della nozione di giurisdizione extraterritoriale, che rischia di lasciare scoperti, sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità fuori dal territorio degli Stati membri, ma sotto la loro influenza operativa o diplomatica.