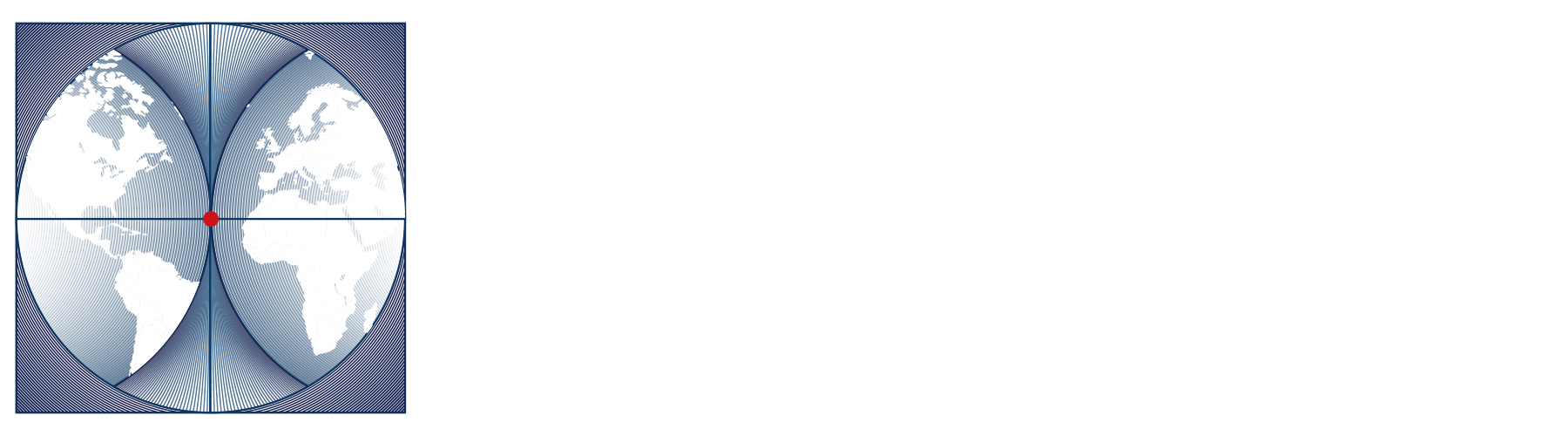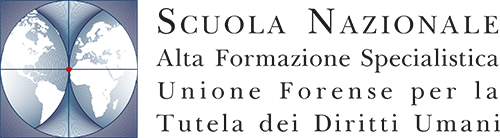di Alessio Sangiorgi
Con un’importante sentenza resa lo scorso 27 maggio nel caso J.L. c. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU (che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare), poiché la sentenza della Corte di Appello di Firenze in un processo per stupro aveva stigmatizzato la vittima attraverso giudizi deplorevoli, non lineari e comunque irrilevanti sulla sua vita privata.
Il caso riguardava un procedimento penale contro sette uomini che erano stati accusati di aver commesso violenze sessuali contro la ricorrente e che sono stati assolti dai tribunali italiani (episodio definito dalla stampa italiana come lo “stupro della Fortezza da Basso”).
La Corte di Strasburgo, nel pronunciarsi sul ricorso, ha stabilito che i diritti e gli interessi della ricorrente ai sensi dell’art. 8 CEDU non fossero stati adeguatamente protetti alla luce del contenuto della sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Le autorità nazionali non hanno protetto la ricorrente dalla vittimizzazione secondaria durante il procedimento, di cui la redazione della sentenza è parte integrante della massima importanza, soprattutto in considerazione del suo carattere pubblico.
In particolare, i giudici europei hanno ritenuto arbitrari e del tutto ingiustificati i commenti riguardanti la bisessualità della ricorrente, le sue relazioni romantiche e le relazioni sessuali occasionali prima degli eventi che sono emersi in corso di dibattimento, talvolta senza alcun rapporto con i fatti.
In altre parole, secondo la Corte europea non è tollerabile che la situazione personale della ricorrente, le sue relazioni sentimentali, il suo orientamento sessuale e finanche la sua scelta dell’abbigliamento, così come lo scopo delle sue attività artistiche e culturali, potessero essere rilevanti per la valutazione della sua credibilità e della responsabilità penale degli imputati. Se ne conclude che le suddette violazioni della privacy e dell’immagine della ricorrente non erano giustificate dalla necessità di salvaguardare i diritti di difesa degli imputati.
Ma vi è di più: nella sentenza di Strasburgo si legge a chiare lettere che il linguaggio e le argomentazioni utilizzate dalla Corte d’Appello di Firenze sono il frutto di pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che rischiano di non proteggere in maniera effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante il quadro legislativo interno sia teoricamente soddisfacente.
Sul punto, la Corte EDU ha ribadito che il processo penale e le relative sanzioni svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza nei confronti delle donne e nella lotta alla disuguaglianza di genere. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi di genere nei loro provvedimenti, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria, anche attraverso un linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario.
Una sentenza che suona come uno schiaffo doloroso al sistema paese, e che tuttavia sembra quanto mai necessario, posto che ancora oggi è prassi, tanto comune quanto ignobile, quella di impostare il processo per stupro come un processo contro le donne, in un tentativo maldestro di sviare strategicamente l’attenzione del collegio giudicante dall’imputato alla vittima.
Fa specie dover constatare che ad oltre 40 anni dalle parole di condanna di questa prassi pronunciate dall’Avvocata Tina Lagostena Bassi, nel celebre processo per stupro del 1979 (trasmesso allora anche dalla RAI), il nostro paese si trovi ancor oggi sovente in una condizione incredibilmente comparabile a quella denunciata con vis – per i tempi – rivoluzionaria dalla compianta Collega.
Parole che ancor oggi riecheggiano nelle nostre menti e che sembrano un triste commento alla recente sentenza di Strasburgo:
“E questa è una prassi costante: il processo alla donna, la vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così, è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un’imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. [..] Una donna ha il diritto di essere quello che vuole, e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella, io sono l’accusatore di un certo modo di fare processi per violenza, ed è una cosa diversa.”.