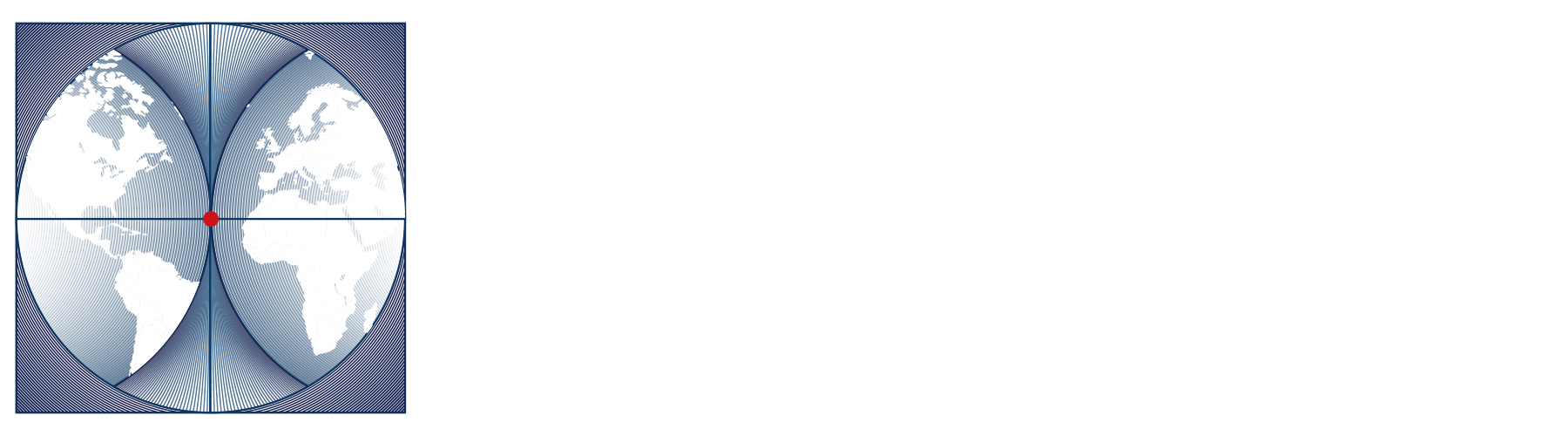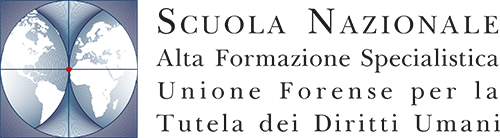di Sara Tosi
La decisione della Corte EDU del 10 luglio 2025 si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale in tema di compatibilità del regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen. con i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione.
In particolare, l’oggetto del giudizio attiene alla limitazione della corrispondenza del detenuto, ridotta ai soli familiari ammessi ai colloqui, che è stata disposta e rinnovata dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 18-ter ord. pen. Il ricorrente lamenta, invocando l’articolo 8 della Convenzione, la non necessarietà di tale limitazione «in una società democratica», specie alla luce della mancanza di un’adeguata motivazione nella decisione interna.
Si rammenta che il 41-bis nasce quale strumento straordinario per recidere i legami tra il detenuto e l’organizzazione criminale esterna, comportando restrizioni incisive sulla vita carceraria: colloqui, contatti, socialità, ricezione di beni. In tale cornice, la corrispondenza rappresenta dunque un punto sensibile, poiché costituisce uno dei pochi canali di comunicazione con l’esterno e, al contempo, uno dei mezzi privilegiati per il mantenimento di rapporti illeciti.
La Corte EDU non mette in discussione in sé la legittimità di un controllo generalizzato della corrispondenza dei detenuti al 41-bis, misura riconducibile alla finalità di prevenzione del crimine e di tutela dell’ordine pubblico (cfr. Provenzano c. Italia n. 55080/13, § 150, 25 ottobre 2018). Tuttavia, essa ribadisce che, quando si incide non soltanto sul controllo ma anche sulla platea dei destinatari, restringendo le comunicazioni ai soli familiari, occorre un quid pluris motivazionale. In altre parole, non è sufficiente il rinvio al ruolo apicale del detenuto o al decreto ministeriale di proroga del 41-bis: l’art. 18-ter ord. pen. esige una motivazione individualizzata e attuale, che dia conto delle ragioni concrete per le quali il controllo non sia sufficiente a neutralizzare il rischio e sia pertanto necessario un ulteriore filtro soggettivo.
In questo senso, la sentenza richiama l’attenzione sul principio di proporzionalità: il sacrificio del diritto alla corrispondenza non può fondarsi su motivazioni stereotipate, ma deve emergere da una valutazione aggiornata del comportamento carcerario, dei rapporti effettivi con l’organizzazione e dell’eventuale utilizzo distorto della corrispondenza.
La pronuncia si colloca così in continuità con un filone giurisprudenziale degno di nota (cfr. Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, § 143, CEDU 2000; Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, §§ 176-180, CEDU 2000-IV), rafforzando il controllo sulle prassi applicative. Il messaggio ai giudici nazionali è lampante: la lotta alla criminalità organizzata non può legittimare una compressione indifferenziata dei diritti. Dunque, le limitazioni ulteriori richiederanno un giudizio autonomo e circostanziato, che eviti automatismi e garantisca al detenuto la possibilità di un sindacato effettivo.