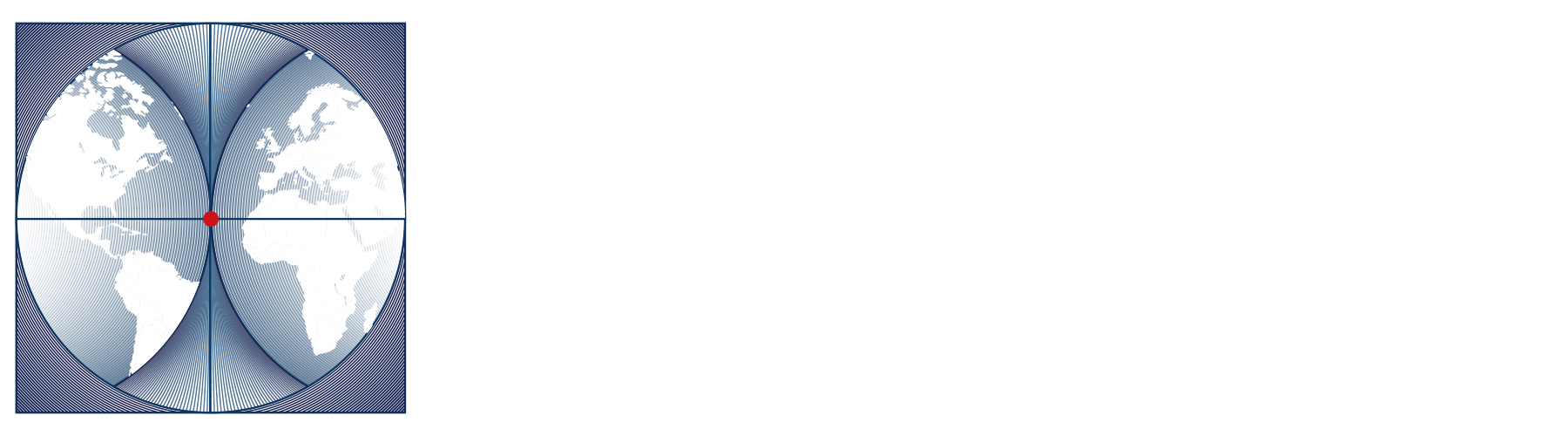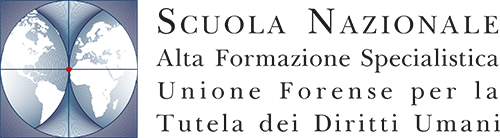di Fabio Militello
Con sentenza n. 76 del 30 Maggio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 Legge 23 dicembre 1978 n. 833, in tema di Trattamento Sanitario Obbligatorio, nella parte in cui non prevede: al primo comma, che il provvedimento del sindaco sia comunicato al soggetto interessato o al suo legale rappresentante; al secondo comma, che il giudice tutelare, in fase di convalida del provvedimento, dia luogo all’audizione della persona interessata; nonché nella parte in cui non impone un obbligo di notifica della convalida o del diniego alla persona interessata o al suo rappresentante.
Tale pronuncia appare evidentemente caratterizzata dall’intento di riassegnare un ruolo centrale e irrinunciabile alla persona investita dal procedimento con cui si dispone un trattamento sanitario obbligatorio, nel momento in cui dalla fase tendenzialmente volontaria (che in ossequio all’articolo 33 l. cit. dovrebbe rappresentare la norma) si trascende alla sua fase coercitiva, garantendo così la sua partecipazione informata e diretta tanto nel momento genetico, quanto in quello eventuale dell’impugnazione del provvedimento.
Il Giudice delle Leggi, valorizzando i principi di cui agli articoli 13 e 32 Cost., alla luce del principio personalista che necessariamente deve permeare il dettato normativo, ha ribadito ancora una volta – ove ce ne fosse bisogno (verosimilmente, intercettando un bisogno latente al giorno d’oggi) – quale debba essere il paradigma interpretativo della legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori, coercitivi e non.
Ed allora, in materia di trattamenti relativi alla salute del singolo consociato, pare così divenire definitivo il passaggio da un’ottica “custodialista” e “paternalista” dell’autorità, ad una visione assistenzialistica e di cura dell’infermo, che pone al centro delle vicende la persona come singolo, titolare di diritti inalienabili e incomprimibili.
Tale evoluzione democraticizzante, avvenuta già all’indomani dell’introduzione della legge Basaglia con la quale era scomparso ogni riferimento alla sicurezza sociale ed al “pericolo di scandalo” quali presupposti per l’agere ab auctoritate, appare quindi rafforzata, cementificata e ribadita attraverso un “invito cortese e necessario” (in passato immotivatamente compresso) rivolto al soggetto, affinché sieda al tavolo della vicenda che lo riguarda da vicino e, qualora lo ritenga opportuno, presenti le proprie istanze.
Un presidio di civiltà e di giustizia volto a ribadire come anche nei casi di malattia psichica, permanente o temporanea, la persona rimanga titolare di diritti inalienabili e personalissimi meritevoli della massima tutela ed esplicazione oltreché insuscettibili di arbitraria compressione.
La centralità del volere e della possibilità di autodeterminarsi del singolo, si esplica anche nella fase più critica della sua vicenda personale, ove venga posto il dubbio circa la sua capacità di volere persino il bene per sé stesso, in ossequio alla tanto ricercata alleanza terapeutica che dal 2017 con legge n. 219 ha tracciato il solco per il superamento di una visione della salute come eteroindotta e promanante da un principio supremo imposto dall’alto.
Una contro-rivoluzione di tolemaica colorazione che, in questo caso a ragione, valorizza il singolo al centro del proprio universo, dettando un paradigma di cui non potrà non tenersi conto nella produzione normativa prossima e futura su temi sensibili e personalissimi quali quelli relativi alla libertà di autodeterminazione e alla individuale percezione di essere o non essere più, in una comunità civile socialmente organizzata.