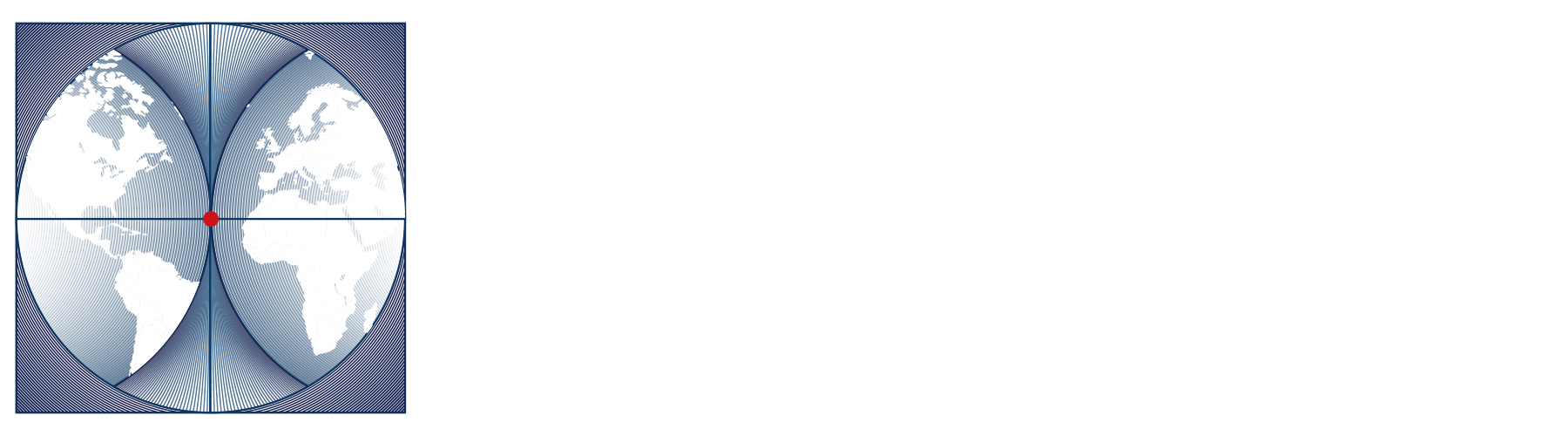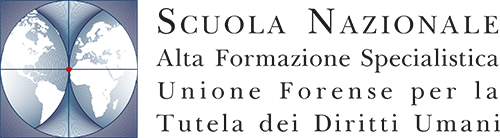di Maria Giusy Schiavone
Con una decisione del 17 ottobre 2025 (ICC-01/11-209), la Camera Preliminare I della Corte Penale Internazionale ha accertato formalmente il mancato rispetto da parte dell’Italia dei propri obblighi in materia di cooperazione giudiziaria, segnando un precedente storico per il nostro Paese.
Il caso riguarda Osama Elmasry Njeem, noto come Almasri, arrestato a Torino il 19 gennaio 2025 in esecuzione di un mandato di arresto internazionale per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi in Libia. Nonostante l’arresto, effettuato su richiesta della CPI, l’Italia ha rilasciato il sospettato il 21 gennaio 2025 e lo ha rimpatriato in Libia con un aereo governativo, senza informare né consultare preventivamente la Corte. Dopo l’arresto, la Corte ha tentato ripetutamente di comunicare con il Ministero della Giustizia italiano per coordinarsi sulle procedure, senza però ricevere riscontri adeguati. Solo il 27 gennaio 2025, diversi giorni dopo il rilascio e il rimpatrio, il Ministero ha informato la CPI che Almasri era già stato riportato in Libia.
Nella sua decisione, la Corte ha esaminato e respinto tutte le giustificazioni avanzate dall’Italia. In primo luogo, l’Italia aveva sostenuto che l’arresto effettuato dalla Polizia Giudiziaria sarebbe stato illegittimo secondo la legge nazionale 237/2012, che non prevederebbe la possibilità per la Polizia di procedere motu proprio. La CPI ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 88 dello Statuto di Roma, spetta agli Stati Parte garantire che la propria legislazione nazionale preveda tutte le procedure necessarie per le forme di cooperazione richieste, e che eventuali ostacoli di diritto interno non possono giustificare l’inadempimento degli obblighi internazionali.
Un secondo argomento riguardava una presunta richiesta di estradizione concorrente avanzata dalla Libia. L’Italia ha sostenuto di trovarsi di fronte a richieste concorrenti e di dover valutare la priorità secondo l’articolo 90 dello Statuto di Roma. Tuttavia, la Corte ha rilevato che l’Italia non ha mai notificato l’esistenza di tale richiesta, come invece espressamente richiesto dall’articolo 90(1), e che questa presunta estradizione è stata menzionata per la prima volta solo il 7 maggio 2025, mesi dopo i fatti. La CPI ha inoltre sottolineato che Almasri non è stato effettivamente estradato, ma rimpatriato come uomo libero, rendendo l’argomento delle richieste concorrenti del tutto inconsistente.
L’Italia ha anche tentato di contestare la validità del mandato di arresto, sostenendo che contenesse “incongruenze” relative al riferimento temporale dei crimini contestati. La Corte ha respinto anche questo argomento, chiarando che si trattava di meri errori tipografici minori, corretti con un corrigendum del 24 gennaio 2025, successivo quindi al rimpatrio di Almasri. La CPI ha ribadito che l’Italia non può, in buona fede, contestare la validità di una decisione emessa in conformità al quadro giuridico della Corte semplicemente perché adottata a maggioranza e non all’unanimità.
Particolarmente grave è stata la violazione dell’obbligo di consultazione previsto dall’articolo 97 dello Statuto di Roma. Questa disposizione impone agli Stati che individuino problemi che potrebbero impedire l’esecuzione di una richiesta di cooperazione di consultarsi immediatamente con la Corte per risolvere la questione. L’Italia non solo non ha mai avviato consultazioni, nonostante la Corte avesse ripetutamente offerto questa possibilità, ma ha agito unilateralmente senza nemmeno informare la CPI fino a diversi giorni dopo. Questo comportamento ha impedito qualsiasi possibilità di dialogo e soluzione delle presunte difficoltà procedurali.
Infine, l’Italia ha invocato ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale per giustificare l’espulsione di Almasri, sostenendo che vi fossero rischi concreti di atti ritorsivi contro cittadini italiani in Libia. La CPI ha osservato che, se Almasri era considerato pericoloso e doveva essere espulso dal territorio italiano, non era chiaro perché fosse necessario riportarlo specificamente in Libia con un aereo di stato. La Corte ha inoltre ribadito che questioni di diritto interno, incluse valutazioni di sicurezza nazionale, non possono essere invocate per giustificare l’inadempimento degli obblighi internazionali.
La decisione accerta all’unanimità che “l’Italia non ha agito con la dovuta diligenza e non ha utilizzato tutti i mezzi ragionevoli a sua disposizione per rispettare la richiesta di cooperazione”. Rilasciando e rimpatriando immediatamente Almasri invece di consegnarlo alla CPI, l’Italia ha impedito alla Corte di esercitare “una funzione fondamentale: assicurare la presenza del sospettato davanti alla giustizia”.
Tuttavia, la maggioranza della Camera ha deciso di differire la decisione sull’eventuale deferimento all’Assemblea degli Stati Parte o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa scelta si basa su due considerazioni: in primo luogo, la Corte ha preso atto che in Italia sono stati avviati dei procedimenti penali davanti al Tribunale dei Ministri di Roma. Richiamando un precedente relativo al Sudafrica, la CPI ha ritenuto opportuno attendere l’esito di tali procedimenti. In secondo luogo, la maggioranza ha considerato la complessità della situazione, incluso il fatto che si trattava della prima volta che l’Italia si trovava a dover cooperare con la CPI per l’arresto e la consegna di un sospettato, pur precisando che tali circostanze non giustificano l’inadempimento accertato.
La Corte ha quindi invitato l’Italia a fornire, entro il 31 ottobre 2025, informazioni sui procedimenti interni rilevanti e sull’impatto che questi potrebbero avere sulla futura cooperazione italiana nell’esecuzione di richieste di arresto e consegna di sospettati.
Vale la pena ricordare che, nel mentre, il Tribunale dei Ministri ha archiviato la posizione della Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha richiesto l’autorizzazione a procedere in giudizio per il Ministro dell’Interno, il Ministro della Giustizia e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzazione che però è stata negata dalla Camera.
Questa decisione rappresenta un precedente significativo per l’Italia e per il sistema di giustizia penale internazionale. È la prima volta che il nostro Paese viene formalmente riconosciuto inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma. La vicenda evidenzia le tensioni che possono emergere tra obblighi internazionali, procedure interne e considerazioni di politica estera, mostrando come la mancata armonizzazione del diritto interno con gli impegni internazionali possa creare situazioni di grave inadempimento.