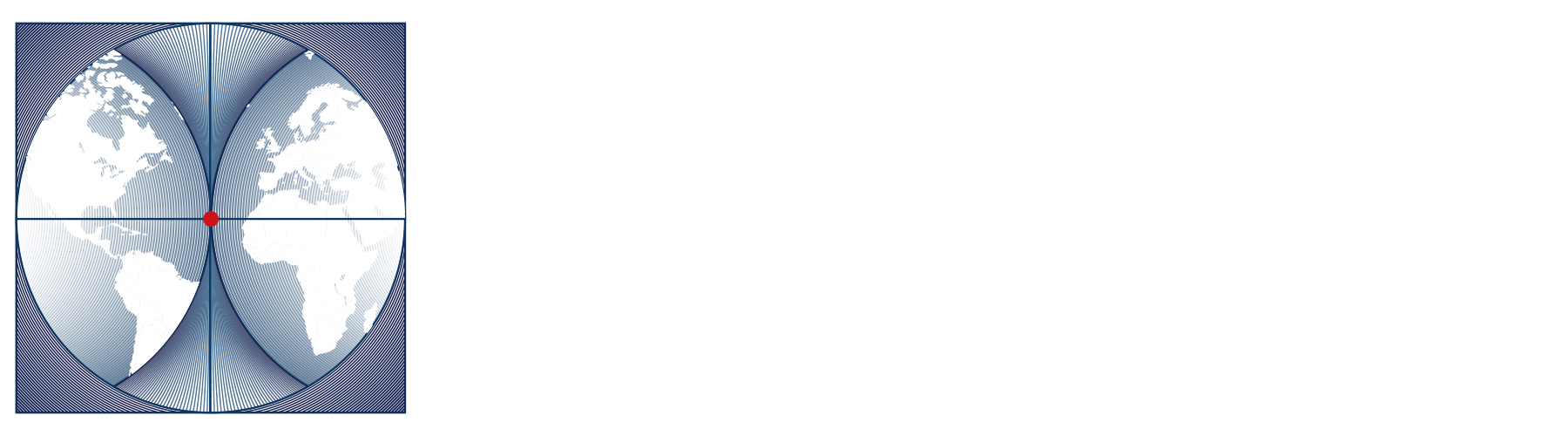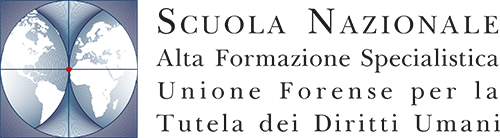di Valentina De Giorgio
Con sentenza del 9 ottobre 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso Petruzzo e altri c. Italia, riguardante la confisca di terreni e fabbricati oggetto del reato di lottizzazione abusiva.
La vicenda traeva origine da due ricorsi presentati da otto cittadini italiani.
Il primo gruppo di ricorrenti (ricorso n. 1986/09) era composto dai comproprietari di terreni situati a Campobello di Mazara (Trapani), per un totale di 97.000 metri quadrati, che tra il 1996 e il 1998 avevano costruito due edifici su meno di 300 metri quadrati di quel terreno, successivamente venduti a terzi. Nel 2001 venivano indagati per lottizzazione abusiva per “cambio di destinazione d’uso del terreno in violazione delle norme urbanistiche”. Nel 2005, il Tribunale di Marsala li assolveva, ordinando la restituzione dei beni sequestrati, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti per configurare il reato ipotizzato. A seguito di appello presentato dalla Procura, nel 2007 la Corte d’Appello di Palermo annullava la sentenza del Tribunale, ritenendo che il reato di lottizzazione abusiva fosse stato commesso perché erano state intraprese azioni contrattuali e materiali che avevano portato a un uso del terreno diverso da quello previsto dalle norme urbanistiche. Il procedimento si concludeva con sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ma la Corte d’Appello ordinava comunque la confisca del terreno e degli edifici. La sentenza veniva poi confermata dalla Corte di cassazione.
Il secondo gruppo (ricorso n. 67556/13) comprendeva i terzi che nel 1998 e nel 1999 avevano acquistato i due appartamenti costruiti dal primo gruppo di ricorrenti. Tale secondo gruppo era rimasto estraneo ai procedimenti di confisca dei loro beni, di cui venivano informati solo in modo informale da un impiegato di banca. Essi avevano avviato un procedimento per ottenere la revoca del provvedimento di confisca, ma i tribunali nazionali avevano ritenuto che non avessero agito con la dovuta diligenza e che avrebbero dovuto sospettare che la proprietà non corrispondesse alla sua destinazione d’uso. Le loro istanze venivano quindi rigrattate. A seguito della registrazione dell’ordinanza di confisca, nel 2013 due ricorrenti del secondo gruppo intentavano un’azione contro il primo gruppo di ricorrenti, chiedendo la risoluzione del contratto di vendita e la restituzione del prezzo di acquisto pagato. Tali richieste venivano accolte dai giudici nazionali.
Entrambi i gruppi di ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 7 CEDU (nulla poena sine lege), sostenendo che era stata loro inflitta una pena imprevedibile in mancanza di una condanna definitiva, nonché dell’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU (tutela della proprietà), in quanto la confisca dei loro beni era stata illegittima e sproporzionata.
Con la sentenza in parola, la Corte di Strasburgo, in relazione all’asserita mancanza di prevedibilità e accessibilità della legge, ha ritenuto che il primo gruppo di ricorrenti avrebbe potuto prevedere che il terreno fosse soggetto almeno alle restrizioni edilizie imposte alle aree non destinate allo sviluppo, dato che ciò era indicato in tutti gli atti delle autorità comunali. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui il reato era imprevedibile alla luce dei permessi comunali, la Corte si è limitata a richiamare la constatazione dei tribunali nazionali secondo cui i permessi di costruzione non erano stati rispettati. Le disposizioni che istituiscono il reato di urbanizzazione abusiva (articoli 18 e 19 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e le norme urbanistiche applicabili) erano quindi sufficientemente prevedibili. Sempre con riguardo al primo gruppo di ricorrenti, in merito alla doglianza di confisca di beni senza condanna formale, la Corte ha affermato che i tribunali nazionali, prima di dichiarare l’intervenuta prescrizione, avevano accertato la sussistenza di tutti gli elementi del reato di urbanizzazione abusiva. La Corte ha ritenuto che tali conclusioni equivalessero, in sostanza, a una condanna ai sensi dell’art. 7 CEDU. In tali circostanze, non ha visto alcun motivo per discostarsi dalle sue conclusioni nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri. Di conseguenza, la Corte ha concluso che non vi era stata violazione dell’art. 7 CEDU nei confronti del primo gruppo di ricorrenti.
Per quanto attiene al secondo gruppo di ricorrenti, la Corte ha osservato che era stata loro inflitta una sanzione nonostante non fossero stati parti nel procedimento penale e non fossero mai stati formalmente accusati di alcun reato. I tribunali nazionali avevano ritenuto che non avessero agito in buona fede e che fossero stati accertati tutti gli elementi costitutivi del reato nei loro confronti. Tuttavia, i ricorrenti non erano stati nemmeno informati che il procedimento penale si era concluso con l’irrogazione della confisca, ma ne erano venuti a conoscenza solo in modo informale. Inoltre, nel procedimento esecutivo non avevano potuto sollevare obiezioni in merito agli elementi costitutivi del reato di sviluppo illegale del sito. La loro capacità di difendersi era stata quindi seriamente limitata, in considerazione delle argomentazioni che avrebbero potuto sollevare se fossero stati parti nel procedimento penale. Di conseguenza, la Corte ha concluso che l’imposizione di una sanzione al secondo gruppo di ricorrenti, senza che essi fossero stati parti nel procedimento penale o fossero stati prima condannati, e sulla base di un accertamento sostanziale di responsabilità nel contesto di una domanda interlocutoria di revisione di un ordine di esecuzione, non era compatibile con i requisiti dell’art. 7 CEDU, che era stato violato.
Per quanto riguarda la violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, la Corte ha ritenuto che il primo gruppo di ricorrenti avesse dovuto sopportare un onere eccessivo e irragionevole. Infatti, i tribunali nazionali avevano ordinato la confisca di tutti i terreni (per un totale di 97.000 metri quadrati), mentre gli edifici costruiti e venduti illegalmente occupavano una superficie inferiore a 300 metri quadrati. La Corte ha riscontrato, altresì, una violazione degli obblighi procedurali di cui all’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU anche nei confronti del secondo gruppo di ricorrenti, che non aveva avuto la possibilità di partecipare al procedimento che aveva portato alla confisca dei loro beni.
La Corte, all’unanimità, ha dunque condannato lo Stato italiano al risarcimento dei danni morali e alla restituzione dei beni confiscati ai ricorrenti del primo gruppo e alla sig.ra Marsala, una delle ricorrenti del secondo gruppo.